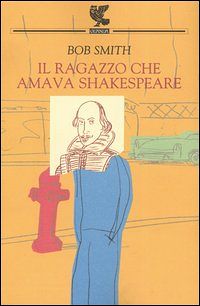
ANTONIO
In verità non so perché sono così triste (Il Mercante di Venezia, I, 1)
In verità non so perché sono così triste…
Le rilessi. Otto semplici, brevi parole, e naturalmente non potevo capire bene che cosa significasse “in verità”, ma non era necessario. Non cambiava affatto la semplice enunciazione, che non avrebbe potuto descrivere in modo più accurato il ragazzino che la stava leggendo. All’improvviso la finestrella colorata sembrava molto più viva sotto il sole del tardo pomeriggio invernale che adesso la colpiva.
Credo che più si è confusi dentro, più si ha bisogno di credere in qualcosa fuori. Avevo un disperato bisogno di appoggiarmi a qualcosa che fosse più grande di me, ed era chiaro che William Shakespeare capiva com’era soffrire senza neppure sapere perché.
In casa nostra vigeva la regola del silenzio. Come molta gente, evitavamo di parlare delle cose di cui più si sarebbe dovuto parlare. Shakespeare diventò così il mio linguaggio segreto, una lingua antica, remota, in caratteri cuneiformi che, in un certo senso mi rendeva più visibile a me stesso. Un processo al quale attualmente assisto in continuazione. Quando un’espressione trasmette al pubblico una verità assoluta che lo accende, vedo la gente emozionarsi e confermare con voce vibrante tale verità: “Sì, sì, è proprio così! È proprio quel ch penso io! Quando l’ha scritto l’autore?”
Naturalmente l’eccitazione che provavo nei confronti di Shakespeare non aveva niente a che vedere con la sua posizione al vertice della letteratura inglese, né che fosse nato anche lui in una cittadina di nome Stratford. Non sapevo niente di lui personalmente, né me ne importava. Leggere Shakespeare era come fissare i calendari religiosi o ascoltare la messa in latino. La poesia divenne così un bellissimo luogo in cui nascondermi dalla mia vita e dai miei genitori, un luogo in cui sapevo che loro non mi avrebbero mai seguito (da “Il ragazzo che amava Shahespeare” di Bob Smith).
Può un romanzo non esente da diversi difetti risultare comunque delizioso e direi persino imperdibile per chiunque ami la letteratura e il teatro? Dopo aver letto “Il ragazzo che amava Shakespeare” la mia risposta è decisamente affermativa.
È un libro autobiografico. L’autore, Bob Smith, con continui rimandi tra passato e presente, racconta da un lato la sua difficile infanzia e dall’altro il suo dolcissimo rapporto con un gran numero di simpatici anziani. E se William Shakespeare ha rappresentato per il bambino Bob la provvidenziale ancora di salvezza per affrontare una realtà personale e familiare dolorosissima, allo stesso modo il grande drammaturgo inglese rappresenta per le vecchiette e i vecchietti, spesso piuttosto malandati, ai quali il “professor” Smith legge amorevolmente gli immortali capolavori, una grande consolazione e una forte motivazione a sentirsi ancora vivi e a vincere la solitudine e la paura della morte.
Il bambino Bob Smith vive in un piccolo paese statunitense chiamato Stratford, proprio come la cittadina inglese sul fiume Avon in cui nacque William Shakespeare. La sua è una famiglia modesta che deve affrontare il dramma di una figlia affetta da gravissima disabilità. Bob ama incondizionatamente la sorellina e si dedica a lei con la massima devozione, ma soffre tantissimo, non solo per la condizione di Carolyn, ma anche e soprattutto per la distanza che lo separa dai genitori. Il padre, reduce dalla guerra, è insensibile e praticamente assente e non si sforza neppure di celare la propria disistima per il figlioletto del quale giunge anche a mettere in dubbio la mascolinità, la madre è fragilissima, nevroticamente accartocciata nel dramma della figlia gravemente ammalata, della infermità della quale in qualche modo sembra persino voler attribuire la responsabilità al piccolo Bob. Il quale non ha nemmeno amici, non solo perché è timido e insicuro, ma anche perché in molti lo evitano per via della sorella.
Bob a dieci anni si sente terribilmente infelice, ma un giorno, recatosi in biblioteca per studiare, apre quasi casualmente un libro, è “Il mercante di Venezia”. Il bambino legge la frase “In verità non so perché sono così triste” e lì cambia il suo destino. Resta profondamente colpito da quelle parole e comincia a leggere le opere di Shakespeare e scopre che esse lo aiutano ad estraniarsi dalla sua dolorosa realtà, a sentirsi meno solo e triste, a sentirsi capito, a “vivere” in un nuovo e meraviglioso mondo. Qualche tempo dopo Stratford ospita un festival teatrale dedicato proprio a Shakespeare e Bob scopre il teatro, diventa servo di scena e da dietro le quinte, e così proprio da vicino, gode dell’interpretazione di grandi attori che rappresentano quei capolavori che lui conosce ormai quasi a memoria e in molti passi dei quali ritrova parallelismi e connessioni con la propria vita. È palpabile la sua sofferenza di bambino sfortunato e problematico, così come lo straordinario effetto terapeutico che hanno su di lui il teatro e in particolare Shakespeare ed è facile immaginare verso quale triste deriva sarebbe andata la sua vita senza quella magica e provvidenziale ancora di salvezza…
Da adulto, poi, Bob organizza seminari con i quali, grazie al suo affetto e grazie alla lettura dei testi shakespeariani, porta conforto e momenti di vera gioia a gruppi di anziani desiderosi di sentirsi ancora amati, meno soli.
Dicevo dei difetti di questo libro… Da più parti è stato rilevato che il romanzo è in alcuni punti prolisso e ripetitivo, mancando di un buon editing e forse anche di una efficace traduzione in italiano, che è troppo lento, che i salti tra passato e presente a volte risultano macchinosi. In parte tutto ciò è forse vero, ma i pregi superano di gran lunga questi limiti.
È un romanzo poetico e commovente, dai temi forti e affascinanti. L’emarginazione cui costringe la disabilità, i drammi e i conseguenti danni psicologici irreversibili che spesso si consumano tra le mura domestiche, il potere salvifico dell’arte e della cultura, la capacità di trovare nella propria sofferenza il desiderio e la forza di andare verso gli altri e di comprenderne e alleviarne la sofferenza, la fragilità e la debolezza cui possono condannare genitori poco attenti, la solitudine cui di frequente sono condannati gli anziani, solitudine per la quale rimedi eccellenti possono essere semplicemente un po’ di affetto e qualche bella lettura in compagnia.
La scrittura di Bob Smith, seppur semplice, è evocativa, spesso lirica, rivelatrice di un animo genuino e dolcissimo, fortemente introspettiva e prodigiosa nella sua grande capacità di comunicare sensazioni ed emozioni.
Le numerose citazioni tratte dalle opere di Shakespeare sono sempre preziose e pertinenti, i dialoghi con gli anziani che seguono i seminari di Smith sono accattivanti, la rievocazione delle passate sofferenze e del grande bisogno di amore dell’autore coinvolgente, la condivisione con il lettore del rapporto del bambino e poi del giovane e dell’adulto Bob con la magia della letteratura e del teatro appassionante.
Al termine della lettura non si potrà non voler bene a Bob Smith (nomen omen, verrebbe da dire pensando al suo desidero di stare sempre… dietro le quinte, di essere anonimo, quasi invisibile) e non desiderare di abbracciare idealmente lui e colui che gli ha salvato probabilmente la vita. Così come non si potrà non desiderare di approfondire la conoscenza delle meravigliose opere di quell’Immortale Genio. E di andare più spesso a teatro.
Date al dolore la parola; il dolore che non parla, sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi (Macbeth, IV, 3).
Michele Bombacigno
